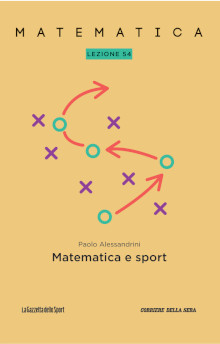Sui margini di una copia di un vecchio trattato di matematica (il secondo volume dell'
Arithmetica di
Diofanto), il più grande dei matematici dilettanti
Pierre de Fermat, scrive queste parole
E' impossibile scrivere un cubo come somma di due cubi o una quarta potenza come somma di due potenze o, in generale, nessun numero che sia una potenza maggiore di due può essere scritto come somma di due potenze dello stesso valore.
In pratica
\[a^n + b^n = c^n, \quad \geq 3\]
Sempre sullo stesso testo, quasi una sfida ai matematici del futuro, Fermat scrisse:
Dispongo di una meravigliosa dimostrazione di questo teorema che non può essere contenuta nel margine troppo stretto della pagina.
Queste poche righe, scritte come l'enunciato del teorema in latino, sono l'inizio di una sfida tra i matematici e Fermat, che tra l'altro, sempre a margine del testo, realizzò una dimostrazione nel caso di $n=4$. La sfida, accolta da alcuni dei più illustri matematici dei secoli successivi, venne sempre e solo in parte vinta, nel senso che ogni matematico che vi lavorò sopra riuscì sempre ad ottenere sempre e solo una dimostrazione parziale o ad ottenere uno strumento utile per la sua dimostrazione definitiva.
Già. La dimostrazione definitiva. Perché una dimostrazione definitiva c'è, ed è quella di
Andrew Wiles, che utilizzando alcuni degli strumenti matematici più potenti e adattandone e, perché no, inventandone altri, è riuscito a realizzare una dimostrazione completa presentata ad un congresso tenutosi a Cambridge nel 1993. Peccato che quella prima dimostrazione conteneva un errore, come si accorse
Nick Katz, uno dei
referee che dovevano esaminare il manoscritto di Wiles per la pubblicazione su
Inventiones Mathematicae, rivista diretta da
Barry Mazur, amico e conoscente, come Katz, di Wiles. Per concludere la dimostrazione, però, Wiles, dopo molti mesi in cui cercò di riprodurre la magica alchimia di solitudine e concentrazione che gli consentì di arrivare ad alcuni importanti risultati, su consiglio di
Peter Sarnak decide di chiedere aiuto ed assistenza ad uno dei suoi ex-allievi, tra l'altro anche uno dei
referee scelti dalla rivista,
Richard Taylor. Grazie all'unione dei due ingegni e ad un'intuizione improvvisa quanto inaspettata anche questo incredibile teorema matematico trova soluzione finale, ottenendo alla fine anche un risultato fondamentale, l'unione tra due mondi matematici separati come le equazioni ellittiche e le forme modulari. La dimostrazione di Wiles, infatti, si basa sulla dimostrazione della
congettura di Taniyama e Shimura (oggi assurta a teorema), due ricercatori giapponesi, due amici molto legati che le vicende della ricerca e della vita separarono indissolubilmente (
Taniyama, ormai vicino al matrimonio, si uccise per non meglio identificati motivi, in una vicenda un po'
alla Majorana).
Tutto questo e molto altro ancore ne
L'ultimo teorema di Fermat di
Simon Singh, uno splendido racconto sulla matematica e su uno dei suoi più ostici teoremi, in cui il giornalista britannico descrive al lettore con chiarezza e passione la storia di un teorema, di una dimostrazione e di tutti coloro che l'hanno affrontata, il tutto tra miti e leggende (il che è inevitabile quando si parla di personalità dell'antichità come
Pitagora, o piuttosto solitarie come lo stesso Fermat, o decisamente molto particolari e sopra le righe come
Evariste Galois).
P.S.: alla fine il manoscritto originale e la correzione alla dimostrazione vennero pubblicati su
Annals of Mathematics:
*
Modular elliptic curves and Fermat's last theorem,
AoM vol.141, No. 3, pag. 443 (pdf via berkeley)
*
Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras,
AoM vol.141, No. 3, pag. 553