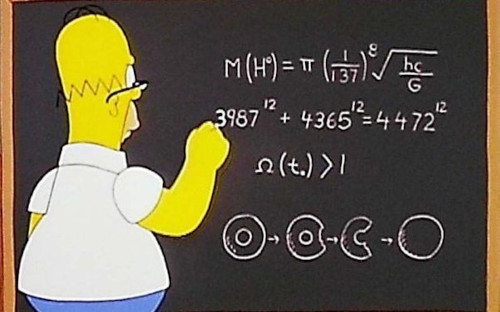
Stomachion
Visualizzazione post con etichetta albert einstein. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta albert einstein. Mostra tutti i post
giovedì 24 aprile 2025
Le grandi domande della vita: Einstein, la matematica e gli scacchi
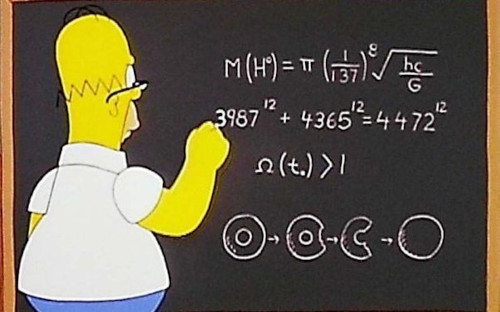
mercoledì 19 febbraio 2025
Le grandi domande della vita: Su Einstein e Hilbert
Per il solito strano caso della vita, qualche giorno più dopo aver pubblicato la puntata dedicata al rapporto tra fisici e matematici (argomento che, comunque, non potrebbe esaurirsi completamente in quelle poche righe), mi ritrovo a rispondere a una domanda sul rapporto tra David Hilbert e Albert Einstein, in particolare sulla leggendaria scarsa considerazione che il primo aveva del secondo, almeno al livello della matematica.
Prima, però, di affrontare questo mito, permettetemi di sfatare un altro mito, quello legato alle competenze matematiche scolastiche del buon Einstein.
Prima, però, di affrontare questo mito, permettetemi di sfatare un altro mito, quello legato alle competenze matematiche scolastiche del buon Einstein.
La pagella di Einstein
Tale mito è molto probabilmente originato da una lettura distratta della sua pagella:
venerdì 14 giugno 2024
Le grandi domande della vita: Tutto è relativo... ma Einstein lo disse sul serio?
L'uscita del 17.mo volume della collana Matematica curata da Maurizio Codogno e dedicato alla relatività è un'ottima occasione per provare a mettere un po' di chiarezza sulla frase più nota attribuita ad Albert Einstein:
Tutto è relativoIn effetti avevo già alcuni appunti di partenza sulla questione: li avevo presi all'epoca della recensione della biografia a fumetti di Nikola Testa realizzata per Beccogiallo da Sergio Rossi e Giovanni Scarduelli. In una delle prime pagine del volume i due personaggi che stanno ricostruendo la vita dell'inventore, si scambiano queste significative battute:
- Guarda che così Tesla farà la fine di Einstein, un professore che diceva che tutto era relativo.E in effetti Einstein era ben distante dal pensare ciò. Prendiamo, per esempio, ciò che scrisse ne Il significato della relatività:
- Beh, sarebbe già un passo avanti, no?
- Sì, però Einstein non ha mai detto quella frase.
Il significato della relatività è stato ampiamente frainteso. I filosofi giocano con la parola, come un bambino con una bambola. Relatività, per come la vedo io, semplicemente denota che certi fatti fisici e meccanici, che sono stati ritenuti positivi e permanenti, sono relativi rispetto ad altri fatti nella sfera della fisica e della meccanica. Ciò non vuol dire che ogni cosa nella vita è relativa e che abbiamo il diritto di rovesciare il mondo intero maliziosamente.Inoltre in una intervista rilasciata a George Sylvester Viereck e pubblicata il 26 ottobre del 1929 sul The Saturday Evening Post afferma:
lunedì 10 giugno 2024
Matematica, lezione 17: La relatività
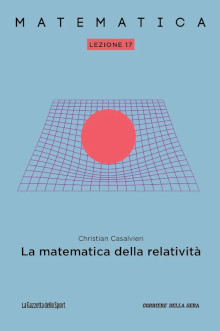
Il punto più delicato della prima parte della trattazione è indubbiamente ricavare le trasformate di Lorentz, scoperte da Hendrik Lorentz giusto qualche anno prima della pubblicazione della teoria di Einstein, e ovviamente fondamentali per essa. Se dal punto di vista di un corso di laurea sarebbe più ovvio e utile ricavarle a partire dalle equazioni di Maxwell (che poi è anche il modo storico con cui sono state ricavate), Casalvieri adotta un approccio più matematico ricavandole a partire dai due postulati o principi di relatività. E di questo il lettore che ha poco presenti le equazioni di Maxwell non può che giorne.
mercoledì 29 maggio 2024
Vite di scienza #10: Arthur Eddington

domenica 30 aprile 2023
La casa di Einstein a Pavia

Alla Certosa siamo arrivati giusto in tempo (ma credo che gli orari sono coordinati con quelli dei treni) per assistere alla visita guidata tra gli spazi interni della Certosa condotti da un monaco della Certosa stessa. E quando la visita è iniziata non lo sapevamo, ma lo abbiamo scoperto nel seguito delle varie tappe:a guidarci, infatti, c'era Domenico De Stradis, il monaco cuoco televisivo. Non poteva esserci, quindi, guida più spigliata nel mostrarci alcuni degli ambienti del monastero e raccontarci i fatti dietro un'opera voluta da Gian Galeazzo Visconti e che è stata compleata in qualcosa come all'incirca un secolo. E' stata sicuramente una visita molto interessante, anche per il contorno un po' gossip: c'erano non solo le fan di don Domenico, ma, come nella più classica carrambata, anche un suo ex-professore dei tempi del liceo!
Poi di nuovo sul treno per andare a vedere Pavia. E qui la visita che vi racconto, anticipata dal titolo. Tutto inizia quando, tornando dalla visita al Borgo Ticino, un vero e proprio paesotto a quattro passi da Pavia, separato solo dal fiume e collegato dal Ponte Coperto, proprio a metà del ponte si trova una targa che ricorda Albert Einstein che passò una parte della sua vita, per quanto una parte breve, proprio a Pavia. In particolare nel 1895 Einstein con tutta la famiglia soggiornò, se la memoria non m'inganna, per un annetto circa a Pavia, dopo aver passato più o meno l'anno precedente a Milano, questo per via di alcuni affari del padre di Einstein in Italia.
giovedì 16 marzo 2023
Le grandi domande della vita: Spaziotempo

Muoversi nello spaziotempo
Probabilmente la domanda era da uno studente bloccato in qualche conto. O magari c'ha pensato di sua sponte. Non lo sapremo mai. In ogni caso è legata alle velocità relative relativistiche. Vi metto qui sotto la domanda (più o meno) integrale prima della mia risposta:
un osservatore A vede due corpi B e C che si muovono in direzione opposta e misura la velocità di ciascuno pari a 2/3 c quindi:La risposta risiede nelle trasformazioni di Lorentz. Queste trasformazioni sono un sistema di quattro equazioni che legano le coordinate spaziotemporali di un punto misurato in un sistema in movimento rispetto a un sistema fermo. Da questo sistema è possibile ricavare le equazioni di trasformazione della velocità. In questo caso, poiché il moto si svolge lungo un'unica direzione, che per comodità chiameremo \(x\), utilizzeremo solo l'equazione lungo questa direzione, poiché nelle altre direzioni la velocità è nulla:
1) A vede B e C allontanarsi reciprocamente ad una velocità di 4/3 c?
2) A quale velocità B vede allontanarsi C? Oppure non lo vede proprio?
sabato 3 luglio 2021
Energize Me
Gli After Forever sono stati una band olandese di genere symphonic metal. Il nome deriva dall'omonima traccia, la seconda, presente in Master of Reality, terzo album dei Black Sabbath. La band, formatasi nel 1995 come doom metal, virò verso il symphonic con l'ingresso della cantante che restò con loro fino allo scioglimento avvenuto nel 2009: Floor Jansen, la stessa che attualmente è la voce dei Nightwish.
Il pezzo che vi faccio ascoltare è Energize Me, tratto dall'ultimo album della band, After Forever, che già nel titolo sembra una celebrazione della carriera della band stessa.
Il pezzo che vi faccio ascoltare è Energize Me, tratto dall'ultimo album della band, After Forever, che già nel titolo sembra una celebrazione della carriera della band stessa.
Energize me with a simple touch or with an open heart
Energize me, fire up this flame that's burning between us
giovedì 29 aprile 2021
Wikiritratti: Henri Poincaré

Lorentz aveva riconosciuto che la trasformazione che porta il suo nome è essenziale per l'analisi delle equazioni di Maxwell, e Poincaré aveva ulteriormente approfondito questo punto di vista.
lunedì 8 giugno 2020
Condominio microscopico
Uno dei modi di vedere la struttura esterna dell'atomo è quella di un grande condominio, per cui ogni piano è occupato da un certo numero di inquilini. Se prendiamo un piano come un livello energetico, e come inquilini gli elettroni, esiste una regola condominiale che impone che ogni orbitale sia occupato al massimo da due elettroni. Questa regola è il principio di esclusione di Pauli.
 La meccanica quantistica era in giro da un ventennio circa quando il fisico indiano Satyendra Nath Bose iniziò a interessarsi di uno dei modelli fondamentali della meccanica quantistica, quello della luce di Albert Einstein. Nel suo annus mirabilis, il 1905, Einstein aveva visto uscire l'articolo che gli valse il Premio Nobel per la fisica nel 1921 sulla spiegazione dell'effetto fotoelettrico. In quell'articolo il fisico teorico suggeriva che la luce fosse suddivisa in piccoli pacchetti, che successivamente sarebbero stati chiamati fotoni.
Una ventina di anni più tardi Bose, durante una lezione presso l'università di Dhaka, presentò ai suoi studenti il problema della catastrofe dell'ultravioletto con l'intenzione di mostrare come la teoria dell'epoca non fosse adeguata per spiegare i fenomeni sperimentali osservati in laboratorio.
La meccanica quantistica era in giro da un ventennio circa quando il fisico indiano Satyendra Nath Bose iniziò a interessarsi di uno dei modelli fondamentali della meccanica quantistica, quello della luce di Albert Einstein. Nel suo annus mirabilis, il 1905, Einstein aveva visto uscire l'articolo che gli valse il Premio Nobel per la fisica nel 1921 sulla spiegazione dell'effetto fotoelettrico. In quell'articolo il fisico teorico suggeriva che la luce fosse suddivisa in piccoli pacchetti, che successivamente sarebbero stati chiamati fotoni.
Una ventina di anni più tardi Bose, durante una lezione presso l'università di Dhaka, presentò ai suoi studenti il problema della catastrofe dell'ultravioletto con l'intenzione di mostrare come la teoria dell'epoca non fosse adeguata per spiegare i fenomeni sperimentali osservati in laboratorio.
Tutti insieme appassionatamente

sabato 2 maggio 2020
Alan Moore: Storie di scienza e magia

Andiamo, però, con ordine, e vediamo come è strutturato l'albo dedicato al bardo di Northampton.
Costruire un omaggio

Nel caso di Moore lo speciale è stato curato con la consulenza di smoky man, ovviamente presente a sommario con un articolo composto da citazioni di Moore che ne identificano il pensiero scientifico e filosofico. Tra gli articoli ho trovato notevoli e interessanti, per vari motivi, quello di Alessandro Bilotta sul suo rapporto con Moore e quello di Adriano Ercolani sul parallelismo di temi e narrativa tra Moore e Bob Dylan. In particolare l'articolo di Bilotta mi ha confermato qualcosa che già pensavo del nostro sceneggiatore sin dai tempi di Giulio Maraviglia: Bilotta è uno dei pochi autori al mondo ad aver veramente compreso il senso dell'opera dello sceneggiatore britannico e ad applicarlo senza fraintendimenti. Ciò potrebbe essere materiale per futuri articoli, ma per il momento mi fermo qui e passo alle storie.
La redazione di Linus per questo speciale ha selezionato tre storie brevi, Continuo a tronare, Se Einstein ha ragione e Lo sbaffo frettoloso del mio sorriso. Quest'ultima storiella, su cui non mi soffermerò più di tanto, disegnata da Peter Bagge, è una vera e propria parodia di un certo modo di fare pubblicità. Nonostante l'interessante argomento, però, mi occuperò principalmente delle altre due storie a sommario.
sabato 28 marzo 2020
Le grandi domande della vita: Il paradosso del disco rotante
Lo so che la principale domanda cui vorremmo tutti una risposta è: quando finiremo nella cosa dei contagi del coronavirus? A questa domanda, però, non è possibile fornire una risposta, almeno una risposta univoca, visto che i modelli sono vari e, soprattutto, i dati non sembrano univoci da regione a regione, almeno limitandoci alla sola Italia.
L'argomento lo riprenderò alla fine dell'articolo con un video del CNR, ma visto che vorrei, per ora, non trattare l'argomento, vi propongo in questa nuova puntata monotematica (o quasi) un argomento di genere relativistico: il paradosso di Ehrenfest.
L'argomento lo riprenderò alla fine dell'articolo con un video del CNR, ma visto che vorrei, per ora, non trattare l'argomento, vi propongo in questa nuova puntata monotematica (o quasi) un argomento di genere relativistico: il paradosso di Ehrenfest.
Disco rotante
Il paradosso parte da un articoletto del 1909 di Paul Ehrenfest(1) in cui il fisico teorico prova a descrivere cosa succede a un disco posto in rotazione con velocità relativistica. L'idea di Ehrenfest era, però, quella di dimostrare che il concetto di rigidità relativistica introdotta da Max Born non può essere applicato alla maggior parte dei corpi rigidi.
martedì 10 marzo 2020
Meraviglioso!

Albert Michelson
Nell'inverno 1931/32 ero un postdoc presso il Kaiser Wilhelm Institut di Berlino-Dahlem. Vebbe organizzato un convegno in memoria di Michelson che era recentemente deceduto(2). Intervennero molti famosi scienziati, incluso R. W. Wood del John Hopkins, che parlò in inglese perché, disse, i suoi amici tedesci gli dissero che se avesse parlato in inglese alcuni di loro lo avrebbero compreso, ma se avesse parlato in tedesco nessuno lo avrebbe capito.
A quel convegno Einstein, parlando in tedesco, racconto la seguente storia su Michelson:
Einstein gli aveva detto: "Conosciamo la velocità della luce con l'accuratezza che ci è necessaria. Perché, allora, vuoi misurarla con maggiore accuratezza?"
E Michelson rispose: "Perché mi diverte" "Das", continuò Einstein, "habe ich wunderbar gefunden!"(3)
martedì 21 gennaio 2020
Un condensato spettrale

Questa, in breve, la trama di Spectral, film di fantascienza di Nic Mathieu distribuito da Netflix. Nonostante la presenza di un personaggio come Clyne, stringi stringi il film si regge essenzialmente sul ritmo incessante e gli ottimi effetti speciali, mentre a livello di trama cavalca il nuovo periodo di tensione tra USA e Russia per costruire una storia che sembri credibile, ma che come al solito si riduce all'essenziale: gli altri combinano i guai e poi arriviamo noi americani, soli al mondo e decimati dalle circostanze, a risolvere la situazione.
Nel mentre della visione, però, si resta catturati dal flusso, per cui il pensiero, che pure nasce durante il discorso del generale statunitense a ciò che resta del suo esercito, viene rapidamente accantonato, travolto dal ritmo cinetico e dalla scoperta scientifica dietro questi misteriosi esseri evanescenti: il condensato di Bose-Einstein.
sabato 28 dicembre 2019
Le grandi domande della vita: Speciale astronomo risponde 2019
Ho cercato in tutti i modi di evitare di rispondere alle domande della rubrica de L'astronomo risponde su Edu INAF, ma in questo 2019 alla fine ben due articoli di questa rubrica sono usciti a mio nome, uno dedicato alla durata di un possibile viaggio interstellare e l'altro dedicato alla stella più grande. Andiamo con ordine e pariamo verso le stelle:
 La domanda è relativa al tempo che servirebbe per viaggiare verso una meta interstellare relativamente vicina a noi. Per questo prendiamo in considerazione Proxima Centauri, una nana rossa a circa 4.2 anni luce dalla Terra nella zona di cielo occupata dalla costellazione del Centauro. Intorno a questa stella si trova un pianeta extrasolare, Proxima Centauri b, la cui scoperta è stata annunciata dall'ESO nel 2016 e che si trova nella zona abitabile della stella. Tra l'altro il pianeta è già stato protagonista di un piccolo giochino matematico con le serie numeriche a metà strada tra Buzzati e la fantascienza. Ad ogni modo, per raggiungere la stella, viaggiando alla velocità della luce, $c$, ovvero 300000 km/s, impiegheremmo all'incirca 4 anni, 2 mesi e un paio di settimane.
La domanda è relativa al tempo che servirebbe per viaggiare verso una meta interstellare relativamente vicina a noi. Per questo prendiamo in considerazione Proxima Centauri, una nana rossa a circa 4.2 anni luce dalla Terra nella zona di cielo occupata dalla costellazione del Centauro. Intorno a questa stella si trova un pianeta extrasolare, Proxima Centauri b, la cui scoperta è stata annunciata dall'ESO nel 2016 e che si trova nella zona abitabile della stella. Tra l'altro il pianeta è già stato protagonista di un piccolo giochino matematico con le serie numeriche a metà strada tra Buzzati e la fantascienza. Ad ogni modo, per raggiungere la stella, viaggiando alla velocità della luce, $c$, ovvero 300000 km/s, impiegheremmo all'incirca 4 anni, 2 mesi e un paio di settimane.
Mentre viaggiamo verso Proxima Centauri il tempo sulla Terra trascorre in maniera differente rispetto a noi che siamo nell'astronave, come spiegava molto bene Carl Sagan nel libro Intelligent life in the universe(1). Per capire questa differenza di tempo ci viene in aiuto la relatività speciale di Albert Einstein. Uno dei risultati di tale teoria è che per un corpo in movimento il tempo si dilata, in sostanza si invecchia di meno rispetto a chi rimane fermo.
Per avere un'idea di tale differenza, supponiamo che la nostra astronave viaggi a una frazione della velocità della luce, diciamo $0.8 \, c$. Questo vuol dire che, per i nostri amici rimasti sulla Terra, la durata del nostro viaggio sarebbe all'incirca di 10 anni, 5 per l'andata e 5 per il ritorno. Per noi che restiamo sull'astronave, invece, il viaggio durerebbe all'incirca 6 anni, 3 per l'andata e 3 per il ritorno. Questa differenza è dovuta al rapporto tra il tempo proprio dell'astronauta, $t_{astronauta}$, e il tempo misurato sulla Terra, $t_{Terra}$, che alla velocità di $0.8 \, c$ è
In viaggio verso Proxima Centauri b

Mentre viaggiamo verso Proxima Centauri il tempo sulla Terra trascorre in maniera differente rispetto a noi che siamo nell'astronave, come spiegava molto bene Carl Sagan nel libro Intelligent life in the universe(1). Per capire questa differenza di tempo ci viene in aiuto la relatività speciale di Albert Einstein. Uno dei risultati di tale teoria è che per un corpo in movimento il tempo si dilata, in sostanza si invecchia di meno rispetto a chi rimane fermo.
Per avere un'idea di tale differenza, supponiamo che la nostra astronave viaggi a una frazione della velocità della luce, diciamo $0.8 \, c$. Questo vuol dire che, per i nostri amici rimasti sulla Terra, la durata del nostro viaggio sarebbe all'incirca di 10 anni, 5 per l'andata e 5 per il ritorno. Per noi che restiamo sull'astronave, invece, il viaggio durerebbe all'incirca 6 anni, 3 per l'andata e 3 per il ritorno. Questa differenza è dovuta al rapporto tra il tempo proprio dell'astronauta, $t_{astronauta}$, e il tempo misurato sulla Terra, $t_{Terra}$, che alla velocità di $0.8 \, c$ è
martedì 22 ottobre 2019
La camminata dell'ubriaco quantistico
Era da un po' che non giravo su arXiv per dare un'occhiata a qualche novità o curiosità non solo su cui scrivere, ma anche da approfondire un po' a tempo perso. Dando un'occhiata alle uscite recenti nel campo della fisica-matematica, mi imbatto in un articolo interessante(4), uscito all'inizio di ottobre, che mi da modo di approfondire un po' l'argomento del moto browniano.
La passeggiata casuale delle cellule in acqua
Sebbene il fenomeno fosse stato osservato per la prima volta nel 1785 da parte del botanico olandese Jan Ingenhousz, il termine deriva dal suo collega scozzese Robert Brown che lo descrisse nel 1827 osservando al microscopio il moto caotico e senza requie delle particelle del polline di Pulchella clarkia nell'acqua. La prima spiegazione teorica del fenomeno arrivò nel 1905 in uno degli articoli che Albert Einstein mandò quell'anno ad Annalen der Physik(1). L'articolo, che studiava il movimento di piccole particelle sospese in un liquido stazionario, aveva come obiettivo quello di fornire un'evidenza per l'esistenza di atomi e molecole. Il modello di Einstein venne successivamente verificato sperimentalmente da Jean Baptiste Perrin nel 1908(2) e gli permise, tra gli altri, di ottenere il Nobel per la Fisica nel 1926
mercoledì 26 giugno 2019
Più a fondo di qualunque bambino

Quando mi domando come mai sia stato proprio io ad elaborare la teoria della relatività, la risposta sembra essere legata a questa particolare circostanza: un normale adulto non si preoccupa dei problemi dello spaziotempo, tutte le considerazioni possibili in merito alla questione sono già state fatte nella prima infanzia, secondo la sua opinione. Io, al contrario, mi sono sviluppato così lentamente che ho cominciato a interrogarmi sullo spazio e sul tempo solo dopo essere cresciuto e di conseguenza ho studiato il problema più a fondo di quanto un normale bambino avrebbe fatto.- Albert Einstein
domenica 19 maggio 2019
Topolino #3312: Una questione di brevetti

Una capatina all'ufficio brevetti
Sebbene l'idea dietro ai brevetti risalga al tempo della Magna Grecia, in particolare alla città di Sibari, la prima vera legge che regolamenta i brevetti risale al 19 marzo 1474, contenuta all'interno dello statuto del senato della Repubblica di Venezia. L'idea fondamentale dei brevetti stessi è quella di stabilire da un lato la paternità di un'invenzione e dall'altro i diritti di sfruttamento della stessa. Il problema è che ciò non azzera le diatribe né protegge completamente gli inventori stessi, questo perché depositare e mantenere un brevetto per un certo tempo costa denaro all'inventore stesso.Il caso più eclatante in questo senso è proprio quello del telefono: per molti anni negli Stati Uniti la co-paternità dell'invenzione ad Antonio Meucci non venne accettata, ritenendo il solo Alexander Graham Bell inventore del dispositivo. Il fatto è che Meucci non poteva permettersi di depositare un brevetto vero e proprio per via dei costi molto più alti, accontendandosi del così detto caveat, che però non prevedeva di depositare un progetto più complesso. Questo, in pratica, lasciava margine per depositare un progetto più completo a chiunque si trovasse a lavorare su un sistema simile, proprio come nel caso di Bell.

venerdì 19 aprile 2019
Le grandi domande della vita: Il buco nero e il gravitone
L'evento centrale di metà aprile è stato il rilascio della prima fotografia di un buco nero. Dopo aver scritto una serie di tre articoli dedicati all'importante risultato scientifico/tecnologico, ritorno sulla questione grazie a una domanda particolare che è giunta sul profilo instagram di Sandro Ciarlariello, di cui prima di iniziare a rispondere alla domanda nel dettaglio segnalo l'articolo dedicato alla questione.
 La domanda è presto detta:
La domanda è presto detta:
Prima di tutto vorrei fissare il punto di vista della relatività generale di Albert Einstein: questa è una teoria geometrica in cui la gravitazione viene interpretata come la deformazione della curvatura dello spaziotempo indotta dalla presenza della massa. Maggiore è la massa, maggiore è la curvatura e quindi il potere di attrarre oggetti verso il centro della curvatura stessa. Un oggetto non cade nel centro della curvatura se ha la sufficiente energia cinetica per muoversi sul bordo della curvatura stessa. In questa descrizione della gravità non è prevista l'esistenza di alcun bosone messaggero, quindi al momento i gravitoni non possono sfuggire dall'orizzonte degli eventi per il semplice motivo che non sono previsti dalla teoria.
Nel frattempo nel 1916 Karl Schwarzschild scopre che all'interno della relatività generale è prevista l'esistenza di singolarità in grado di curvare lo spaziotempo così tanto che neanche la luce è in grado di sfuggirvi(2). La possibile esistenza delle singolarità di Schwarzschild non andava a genio al buon Einstein, che scrisse un articolo di 16 pagine per dimostrare come tali singolarità non possono esistere nella realtà fisica(3), affermazione che in qualche modo sembra riecheggiare l'obiezione che il famoso fisico teorico rivolse alla meccanica quantistica.
Una questione di gravitoni

Se la gravità fosse mediata da gravitoni, come farebbero questi a uscire dall'orizzonte degli eventi?Non è la prima volta che questa domanda viene posta, quindi si riescono a trovare un po' di risposte in giro, ma nessuna di queste mi è sembrata sufficientemente soddisfacente(1), così provo a fornire una mia personale risposta.
Prima di tutto vorrei fissare il punto di vista della relatività generale di Albert Einstein: questa è una teoria geometrica in cui la gravitazione viene interpretata come la deformazione della curvatura dello spaziotempo indotta dalla presenza della massa. Maggiore è la massa, maggiore è la curvatura e quindi il potere di attrarre oggetti verso il centro della curvatura stessa. Un oggetto non cade nel centro della curvatura se ha la sufficiente energia cinetica per muoversi sul bordo della curvatura stessa. In questa descrizione della gravità non è prevista l'esistenza di alcun bosone messaggero, quindi al momento i gravitoni non possono sfuggire dall'orizzonte degli eventi per il semplice motivo che non sono previsti dalla teoria.
Nel frattempo nel 1916 Karl Schwarzschild scopre che all'interno della relatività generale è prevista l'esistenza di singolarità in grado di curvare lo spaziotempo così tanto che neanche la luce è in grado di sfuggirvi(2). La possibile esistenza delle singolarità di Schwarzschild non andava a genio al buon Einstein, che scrisse un articolo di 16 pagine per dimostrare come tali singolarità non possono esistere nella realtà fisica(3), affermazione che in qualche modo sembra riecheggiare l'obiezione che il famoso fisico teorico rivolse alla meccanica quantistica.
venerdì 22 marzo 2019
Il fiume del tempo
cc @stefacrono @astrilari @cosmobrainonair @Pillsofscience @real_fabristol @Scientificast @mediainaf
Non avevo molta voglia di scrivere nulla di troppo lungo, ma mi sono accorto che la serie di articoli su 01011001 degli Ayreon di Arjen Anthony Lucassen era ferma da un mese, sempre rinviata per vari motivi, così eccomi qui, pur nell'ora tarda, a concludere questa prima trilogia dedicata agli Ayreon.
Dopo The Fifth extinction, dedicata all'estinzione dei dinosauri, il sommario del secondo cd di 01011001 prosegue con alcuni spunti interessanti sull'evoluzione nella quarta traccia, Unnatural selection, per poi proseguire con due canzoni dal contenuto relativistico, The river of time e $E=mc^2$, che accorpo insieme per ovvi motivi.
Estratti dal testo

The mystery solved, the answer to lifeVi ricordo che i Forever, protagonisti del concept album degli Ayreon, hanno cercato una casa per il loro patrimonio genetico. Una volta mandato sulla Terra, genera gli esseri umani, che però sembrano indirizzati verso lo stesso destino da cui hanno cercato di sottrarsi i Forever, che quindi discutono di una soluzione finale, un'occasione per sopravvivere.
The final solution, a chance to survive
We can save this ill-fated raceIn qualche modo la soluzione propone un vagheggiato viaggio nel tempo, possibile solo andando più veloci della luce. E più o meno è anche quello che pensano i due scienziati del XXI secolo protagonisti della successiva $E=mc^2$:
Who are lost in the ocean of space
Show them the way to reverse their decline
Guide them back on the river of time
Follow the wave, speed up the flight
Slow down time, faster than light
It all came to me in the wake of a dreamPer ottenere lo scopo, però, bisogna
Bending space, reversing the stream
The knowledge is mine to influence time
And avert our decline (we'll avert our decline)
Let's break the equation... $E=mc^2$Le due canzoni, poi, oltre ad avere una continuità tematica molto stretta, sono anche musicalmente la seconda continuazione della prima in un vero percorso narrativo continuativo senza interruzione se non per i protagonisti, interpretati da Hansi Kürsch dei Blind Guardian e Bob Catley dei Magnum per The river of time e dall'olandese Wudstik e da Marjan Welman per $E=mc^2$.
Iscriviti a:
Post (Atom)




