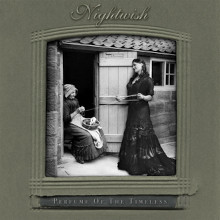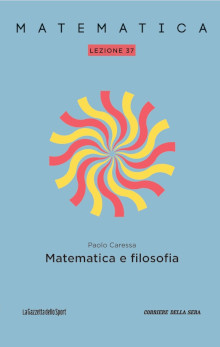Due i principali protagnisti di questa edizione: il tempo (che mi ha permesso di riciclare, con nuova impostazione, quanto avevo scritto per la
recensione di OraMai di Tuono Pettinato) e il
pi greco, inserito per l'avvicinarsi del
pi day, ricorrenza che come ogni anno non mancheremo di festggiare tutti inseme!
L'oscuro mistero del tempo

Ilya Prigogine secondo Tuono Pettinato
Ben due domande sul tempo:
una sulla sua linearità e l'altra sul fatto di
essere una dimensione o qualcosa d'altro. Entrambe le domande sono due aspetti di quella più generale sulla natura del tempo.
Secondo
Albert Einstein (che non ci abbandona mai in questa serie!), il tempo è
Quella cosa che si misura con l'orologio.
D'altra parte il Premio Nobel per la Chimica
Ilya Prigogine propose le idee, forse inquietanti, di tempo termico e freccia del tempo, ovvero esiste una direzione che, una volta intrapresa, non può essere percorsa al contrario: il piatto che si rompe, non si ricompone; l'uomo che invecchia, non ringiovanisce; e così via. Questa definizione è fortemente legata all'entropia e viene descritta con grande leggerezza da
Carlo Rovelli:
La caratteristica più saliente del tempo è che va avanti e non indietro, cioè la sua irreversibilità. È l'irreversibilità a caratterizzare ciò che chiamiamo tempo. I fenomeni "meccanici", cioè i fenomeni in cui non entra il calore, sono sempre reversibili. Cioè, se li filmate e li proiettate all'indietro vedrete fenomeni perfettamente realistici. Per esempio filmate un pendolo, oppure un sasso lanciato verso l'alto che sale e poi ridiscende, e guardate il film al contrario, vedrete ancora un ragionevolissimo pendolo, o un ragionevolissimo sasso che cale e poi ridiscende. Ah! direte voi, ma non è vero! Quando il sasso arriva a terra si ferma, se guardo il film vedo un sasso che salta da solo a partire dalla terra, e questo è impossibile. Esatto, e infatti quando il sasso arriva a terra si ferma, e dove va la sua energia? Va a scaldare la terra su cui è caduto! Si trasforma in un po' di calore. Nel preciso momento in cui si produce calore, avviene un fenomeno irreversibile: un fenomeno che chiaramente distingue il film diritto da quello rovescio, il passato dal futuro. È sempre il calore, in ultima analisi, a distinguere il passato dal futuro.
Dal punto di vista strettamente matematico il tempo è, in ogni caso, una delle quattro dimensioni geometriche dello spazio in cui siamo immersi, quindi è una dimensione come quelle spaziali, ma abbiamo bisogno di distinguerle attraverso una geometria non euclidea, che si è dimostrata più efficace per consentire alla fisica di descrivere il nostro universo.
Il modo con cui viviamo il tempo è, però, soggettivo, legato al modo con cui interagiamo con le condizioni esterne: con questa idea in testa
Claudia Hammond ha ideato alcuni esperimenti per valutare la precisione del cosìddetto "orologio interno", usualmente precisissimo a meno di situazioni stressanti.
Quindi il tempo è una dimensione che però non siamo in grado di percorrere in entrambe le direzioni, essendo legato a fenomeni irreversibili, e lo sperimentiamo in termini soggettivi.
E la sua linearità? In termini matematici, questa è una proprietà di una relazione o di una funzione rappresentabile attraverso una linea dritta. E il tempo è lineare, come funzione della posizione e della velocità, solo nel moto rettilineo uniforme, mentre già in quello uniformemente accelerato il tempo è quadratico. Imagino, però, che il lineare sia inteso come sinonimo di sequenziale, ma a questo punto bisognerebbe chiedersi: è il tempo, che è una delle dimensioni dell'universo, ad essere sequenziale o sono gli eventi che in esso accadono a essere sequenziali? E secondo me è più corretto parlare di eventi sequenziali e non di tempo sequenziale. Ed è anche abbastanza ovvio che tutte queste domande sul tempo non ce le porremmo senza l'invecchiamento!