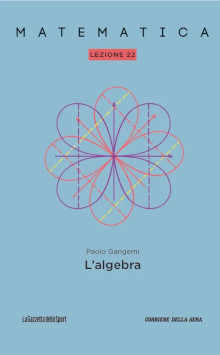Puntata uscita con un giorno di ritardo: la lettura prima di tutto. E poi dovevo anche smettere di ridere!
Ritorna in edicola la mitica
Ridi Topolino, con una raccolta speciale di alcune delle storie inedite uscite sul bimestrale e realizzate da
Tito Faraci e
Giuseppe Ferrario. Se Panini ci delizierà ancora una volta con questa rivista, solo il tempo ce lo dirà, ma è certo che è stata di ispirazione non solo per la carriera fumettistica di un tale di nome
Sio, ma anche questa puntata de
Le grandi domande della vita (e forse in qualche angolino del mio cervello anche della rubrica stessa!).

da
Ridi Topolino #3
, ci sono volute 300 e più pagine a
Bertrand Russell e
Alfred North Whitehead per dimostrare che $1+1=2$. Questo è un esercizio abbastanza complicato quando si vuole scendere nelle profondità del mare matematico, oppure ecessivamente banale quando, alla domanda, si fornisce la risposta,
perché $2$ è definito come $1+1$. Una dimostrazione, che forse non avrà la completezza formale di quela di Russell, ma che è anche didatticamente utile, può tranquillamente utilizzare i postulati del matematico italiano
Giuseppe Peano:
- $1$ è un numero appartenente a $N$
- Se $x$ è un numero in $N$, allora il suo sucessore $x'$ è in $N$
- Non esiste alcun $x$ tale che $x' =1$
- Se $x$ non è $1$, allora esiste un $y$ in $N$ tale che $y' = x$
- Se $S$ è un sotoinsieme di $N$, $1$ è in $S$, e l’implicazione $X \in S \Rightarrow x' \in S$ è vera, allora $S=N$
Allora si definisce ricorsivamente la somma:
Siano $a$, $b \in N$. Se $b=1$, allora, utilizzando i postulati 1 e 2, $a+b = a'$. Se $b$ è diverso da $1$, alora sia $c' = b$, con $c \in N$ (dal postulato 4), e per definizione $a+b=(a+c)'$.
llora devi definire $2 = 1'$.
Dalla sua definizione e dai postulati 1 e 2, segue che $2 \in N$.
Possiamo allora dimostrare che $1+1=2$:
Prendiamo la definizione della somma e applichiamola al caso in cui $a=b=1$:
\[1+1=1'=2\]
Esiste una formulazione differente dei postulati di Peano che sostituisce l'$1$ con lo $0$ nei postulati 1, 3, 4, 5. Questo costringe a modificare la definizione della somma:
Siano $a$, $b \in N$. Se $b=0$, allora per definizione $a+b = a$. Se $b$ è diverso da $0$, allora sia $c' = b$, con $c \in N$, e per definizione $a+b=(a+c)'$.
Quindi si definiscono $1 = 0'$, e $2 = 1'$. La dimostrazione del teorema sulla somma delle due unità diventa leggermente differente:
Utilizzando la seconda parte della definizione della somma si ottiene:
\[1+1=(1+0)'\]
e utilizzando la prima parte nelle parentesi si ottiene:
\[1+1=(1)'=1'=2\]