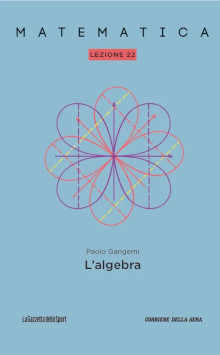Una delle più importanti rivoluzioni che il mondo ha visto è stata quella scientifica, fatta di storie piccole che con la forza della conoscenza hanno modificato alcuni aspetti della vita quotidiana. Il periodo però chiave per questa rivoluzione, quanto meno dal punto di vista
Occidentale, parte con la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento. Se, infatti, si contano scienziati che, più o meno separatamente, anche nel tempo (vedi
Jabir ibn Hayyan), hanno cercato di introdurre elementi sistematici nelle discipline scientifiche, è proprio in questo lasso di tempo che iniziano a farsi largo una serie di figure storicamente importanti per la scienza in generale. E molti di questi personaggi ebbero anche problemi con le istituzioni religiose, o comunque con il pensiero comune del tempo. Ad esempio
Leonardo da Vinci, che anticipò la rivoluzione scientifica di mezzo secolo almeno, portava avanti più o meno clandestinamente le sue operazioni di dissezione dei cadaveri (7). Di
Galileo,
Kepler,
Copernico le difficoltà in vita con la Chiesa sono, poi, note. E difficoltà analoghe le ebbe anche
Thomas Harriot, matematico, astronomo, navigatore britannico, che venne accusato in maniera più o meno esplicita di ateismo insieme con sir
Walter Raleigh, al cui servizio lavorò come navigatore, in particolare per alcune spedizioni nel
nuovo mondo. In particolare sembra che fece parte di una prima spedizione che, salpata verso la famosa Roanoke, doveva preparare il terreno per la prima colonia britannica nelle terre
scoperte da
Colombo nel 1492. Ciò che è certo è che al suo rientro in patria scrisse e pubblicò nel 1588 un resoconto,
A Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia, che però sembra essere solo una versione breve di un più ampio e dettagliato resoconto, rimasto introvabile
(1).
E' in ogni caso questo il momento in cui arrivano su Raleigh le accuse di ateismo, che inevitabilmente allontanano il matematico dall'esploratore. Harriot si era avvicinato a Raleigh grazie alla sua laurea in matematica, che dallo studio di alcuni documenti ufficiali, ha conseguito nel 1580 a Oxford, dove si era iscritto tre anni prima all'età di 17 anni. Thomas riuscì a far fruttare questa laurea nel campo della navigazione, anche grazie all'interesse di Raleigh nello sfruttamento della disciplina per migliorare la navigazione, come scrive ad esempio Hakluyt:
Ever since you perceived that skill in the navigator's art, the chief ornament of an island kingdom, might attain its splendour amongst us if the aid of the mathematical sciences were enlisted, you have maintained in your household Thomas Harriot, a man pre-eminent in those studies, at a most liberal salary, in order that by his aid you might acquire those noble sciences in your leisure hours ...(1)
I progressi ottenuti da Harriot, e quindi la fiducia nelle sue capacità, non si fanno attendere, come testimoniato da Pepper:
... he solved the problem of reconciling the sun and pole star observations for determining latitude, introduced the idea of using solar amplitude to determine magnetic variation and, as well as improving methods and devices for observation of solar or stellar altitudes, he recalculated tables for the sun's declination on the basis of his own astronomical observations. ... he produced a practical numerical solution of the Mercator problem, most probably by the addition of secants ...(1)
La fama di Raleigh di
miglior navigatore del suo tempo è dunque dovuta essenzialmente ai progressi di Thomas Harriot, che nel momento in cui il suo primo mecenate iniziò a perdere potere, decise di cambiare datore di lavoro, passando alle dipendenze di
Henry Percy, duca di Northumberland. Il rapporto con Percy gli permise di entrare a far parte della casta della
nobiltà terriera, ovvero di quella fascia di popolazione che, pur non avendo alcuna origine nobiliare, era riuscita ad ottenere dei possedimenti.
(1)
In questa situazione economicamente stabile il matematico scoprì una serie di risultati, che però non gli furono completamente attribuiti a causa di una mancanza di pubblicazione degli stessi. Uno degli esempi in questo senso è certamente la legge di rifrazione, che oggi porta il nome di
legge di Snell e scoperta da questi nel 1621, ovvero 20 anni più tardi, come risulta dagli appunti, della scoperta di Harriot. La stessa scoperta di Snell venne pubblicata nel 1637 e non da Snell, ma da Cartesio.
(1)
Un altro problema ottico che interessò Harriot fu il
problema di Alhazen.
Abū ʿAlī al-Ḥasan ibn al-Ḥasan ibn al-Haytham, noto anche come
Ibn al-Haytham o
al-Basri, latinizzato in
Alhacen e poi divenuto anche
Alhazen, è stato un filosofo, astronomo e matematico arabo vissuto tra la fine del primo e l'inizio del secondo millennio. Uno dei suoi principali interessi fu nell'ottica, della quale è considerato uno dei padri, raccogliendo le sue osservazioni in un trattato, pubblicato in latino con il titolo
Opticae thesaurus(3). Il trattato venne pubblicato in Occidente per la prima volta nel 1572 e il problema con la sua soluzione vengono raccontati alle pagine 144-148 di quell'edizione, nelle proposizioni 34, 38 e 39
(3). Il problema possiamo così enunciarlo: