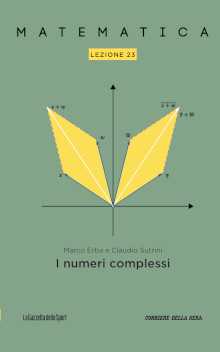
A parte il secondo capitolo, più tecnico e lungo, gli altri propongono un approccio comunque molto divulativo, presentando un po' di storia sui numeri complessi, alcune applicazioni, in particolare nell'ambito della fisica e un ultimo capitolo più... filosofico, che dal punto di vista di un fisico teorico è stato piuttosto interessante. Emerge, infatti, la forte idea, secondo me un po' irrealistica, dei fisici di voler dare un senso di realtà ai modelli matematici che descrivono i fenomeni fisici, e non pensarli come dei semplici strumenti che, pur con una certa imprecisione, che è inevitabile nella descrizione del mondo, sono utili per orientarsi all'interno della conoscenza.
Di fatto la sensazione che emerge dalle citazioni illustri presenti nel libro è proprio quella che i fisici non siano, ancora oggi, riusciti a fare i conti con i numeri immaginari, a differenza dei matematici, più avvezzi al pensiero astratto. Il che, forse, mi spinge a consigliare il libro soprattutto ai fisici e poi a tutto il resto del mondo!
Per la sezione biografica Sara Zucchini ci racconta Bertand Russell, il logico e matematico vincitore del premio Nobel per la letteratura che cercò di seguire il sogno di David Hilbert di costruire le fondamenta della matematica. Il suo approccio partì dai lavori di Giuseppe Peano, ma alla fine si scontrò con i teoremi di incompletezza di Kurt Godel. Certo, se pensiamo al suo famoso paradosso, noto in termini divulgativi come il paradosso del barbiere, probabilmente ci andò molto vicino a scoprirlo, ma proprio perché in un certo senso "accecato" dal suo stesso programma, non se ne avvide.
Infine due parole sui giochi matematici di Maurizio Codogno che proseguono sulla falsa riga di quelli presenti nel volume precedente (ma questa volta non ci sarà alcun paralipomeno ispirato a essi... mi spiace).
In ogni caso l'argomento iniziato con questa 23.ma lezione verrà proseguito, stando al piano dell'opera, con il prossimo volumetto.


