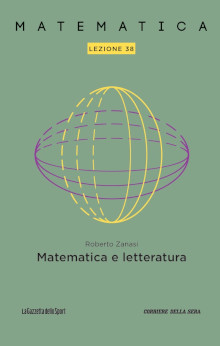La storia inizia, come intuibile dal titolo, dall'
Inferno di
Dante, che dei tre canti della
Commedia è sicuramente quello più noto e che ha maggiormente colpito l'immaginario popolare, non solo per la lingua utilizzata, certamente più semplice, ma anche per le immagini e per la sua presunta posizione da qualche parte nelle viscere della Terra (forse sotto Gerusalemme, seguendo la tradizione dantesca).
Ovviamente all'uscita dell'opera di Dante sono seguite le
recensioni dell'epoca, chiamate
commenti, che in effetti erano qualcosa di più di semplici recensioni. In particolare all'epoca di Galileo le due interpretazioni dell'opera dantesca più gettonate erano sicuramente quelle di
Manetti, fiorentino, appartenente all'epoca dell'Accademia delle Scienze di Firenze, poi Accademia della Crusca, e di
Vellutello, veneziano. Le due posizioni erano differenti, opposte, viene tramandato, e così è necessario dirimere la questione, e l'unico che è in grado di farlo è solo un matematico, possedendo egli le qualità per esaminare la questione sia dal punto di vista scientifico (utilizzato soprattutto da Manetti), sia da quello umanistico, essendo questo tipo di formazione piuttosto di base all'epoca. L'unico matematico che decise di accettare la sfida fu proprio
Galileo Galilei, che non accettò semplicemente per amore della sfida, ma soprattutto per poter andare a Firenze e riuscire magari ad ottenere un impiego stabile e ben remunerato. Nascono così le due lezioni che Galileo dedicò, nel
1587, ai due saggi sull'
Inferno di Dante, alla fine delle quali il matematico e fisico pisano affermò che l'esame scientificamente più corretto dell'opera dantesca fosse quello di Manetti (e d'altra parte non c'erano dubbi sull'esito, essendo Galileo pagato proprio da Firenze!).
Di queste due lezioni, il Politecnico di Milano, attraverso il Dipartimento di Matematica e il Laboratorio Didattico FDS, ha scelto la prima per realizzare un (primo) progetto di collaborazione con gli artisti dell'Accademia di Brera. Gli studenti dell'Accademia, in effetti, non era la prima volta che collaboravano con gli scienziati, essendo già avvenuto in occasione della mostra
L'universo dentro, realizzata insieme con l'Osservatorio Astronomico di Brera (fu quindi un po' come giocare in casa!). In questa occasione gli studenti della professoressa Angelini si sono, invece, occupati di matematica, una disciplina che si presta altrettanto bene rispetto all'astronomia, se non anche meglio considerando le reinterpretazioni in chiave geometrica della realtà tipiche di moltissimi artisti del XX secolo.