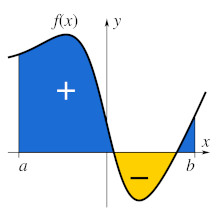Le origini della teoria dei gruppi sono drammatiche, nel senso che i due principali matematici che posero le fondamenta di questa branca della matematica evvero due vite piuttosto drammatiche conclusesi entrambe in giovane erà. Il primo dei due fu il norvegese
Niels Henrik Abel, la cui biogfrafia viene così riassunta da
Mario Livio ne
L'equazione impossibile(1):
Che cosa si può dire di un ragazzo morto a ventisei anni? Che era timido e geniale. Che amava la matematica e il teatro. E che fu condannato a morte dalla povertà.

Nato il
5 agosto del 1802 dal pastore luterano
Soren Georg Abel e da
Anne Marie Simonsen, figlia di un mercante, immagino non ebbe certo un'infanzia semplice, tra un padre religioso e una madre, per così dire, allegra. Si possono solo immaginare le discussioni tra i due coniugi, discussioni che potrebbero aver influenzato il carattere di Abel ben più della figura paterna, che istruì personalmente Niels fino ai 13 anni, quando poi venne mandato alla Scuola Cattedrale di Christiania, l'attuale Oslo. Probabilmente l'allontanamento da una famiglia difficile (entrambi i genitori erano sostanzialmente alcolizzati) fu la prima delle poche fortune che la vita gli concesse. La seconda, in ordine di tempo, fu
Bernt Michael Holmboe, giovane insegnante di matematica giunto alla Scuola Cattedrale per sostituire
Hans Peter Bader allontanato a causa delle denunce di maltrattamenti inoltrate dai suoi studenti, tra cui lo stesso Niels.
Holmboe, in effetti, fu molto importante per Abel: innanzitutto introdusse un nuovo programma molto più moderno e poi, accorgendosi del talento matematico di Niels, lo incitò a leggere le opere di grandi matematici come Laplace, Newton, Gauss, Lagrange. E forse anche grazie agli entusiastici giudizi del suo insegnante durante il suo ultimo anno alla Scuola Cattedrale provò la grande sfida dell'epoca, risolvere una equazione di quinto grado usando gli strumenti più semplici di somme, moltiplicazioni e radici. Il giovane sottopose questo suo primo lavoro proprio al suo insegnante, il quale ritenendolo perfetto, lo inoltrò all'Università di Christiania, in particolare a
Christopher Hansteen e
Soren Rasmussen, che convennero con il giudizio di Holmboe. A questo punto l'insegnante inviò il manoscritto a
Ferdinand Degen di Copenhagen per farlo pubblicare dall'Accademia Danese. Degen, da buon
reviewer, chiese ad Abel una descrizione più dettagliata del risultato aggiungendo anche degli esempi numerici. E proprio alla ricerca di esempi, Niels si accorse che la sua soluzione era errata. Degen, però, gli consigliò di rivolgersi ad altri campi, come ad esempio gli integrali ellittici, perché avrebbero potuto riservare risultati e soddisfazioni migliori dello studio delle equazioni.
E in effetti Abel, entrato all'università nel 1821, grazie all'impegno di ben tre professori, tra cui Hansteen e Rasmussen, che finché poterono anche negli anni successivi cercarono di sostenere Niels anche dal punto di vista economico. Fu in effetti il terzo evento felice della vita di Abel, visto che usciva da un periodo familiare difficile, ricco di stenti e con l'insuccesso politico del padre, che cercò di diffamare senza successo due suoi colleghi di parlamento. Se l'insuccesso influenzò pesantemente il padre e la famiglia, certo non influenzò più di tanto la carriera accademica di Abel, almeno dal punto di vista scientifico, perché dal punto di vista dei finanziamenti già allora le istituzioni accademiche preferivano sostenere economicamente l'esperienza piuttosto che la bravura e il talento.
Senza, però, anticipare troppo, torniamo ai primi lavori scientifici di Abel, usciti tra il 1823 e il 1824. In particolare si segnala il suo terzo manoscritto,
Soluzione di una coppia di proposizioni per mezzo di integrali definiti, dove si trova la matematica che farà da base alla radiologia moderna. Fu poi nel 1823 che Abel ebbe i primi contatti con matematici europei, quandopassò l'estate di quell'anno da uno zio a Copenaghen, dove conobbe anche la sua futura fidanzata, l'unica donna della sua vita,
Christine Crelly Kemp. Il loro fidanzamento venne ufficializzato dopo il Natale del 1824, ma non riuscirono mai a concludere il loro sogno di un matrimonio e una vita insieme sia per le ristrettezze economiche (Niels non riuscì mai a ottenere un contratto stabile ed economicamente sufficiente per una famiglia, Crelly non andò mai semplici lavori da istitutrice) sia per il peggioramento delle condizioni di salute di Niels, preda della tubercolosi,contratta molto probabilmente durante il viaggio in Europa, forse a Parigi.
Infatti Hansteen e Rasmussen riuscirono a strappare un pur esiguo finanziamento dal Ministero delle Finanze per mandare Abel in Europa presso alcune università del continente. Tra i vincoli imposti dal Ministero, in particolare uno influenzò le finanze di Niel al suo ritorno in patria:
(...) Abel non avrebbe ricevuto denaro dopo il suo rientro in Norvegia.