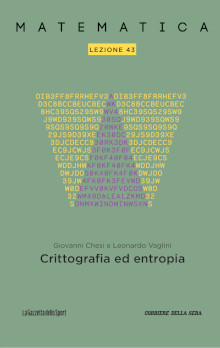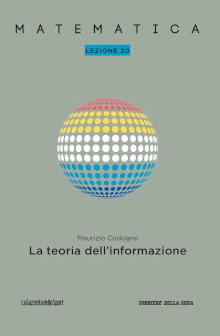Alla domanda su
"chi siamo?" prova a rispondere, in maniera apparentemente sorprendente
Essere umani di
Brian Christian, poeta e vincitore del titolo di
"umano più umano" nel 2009.
La storia inizia con il
premio Loebner, una competizione internazionale tra intelligenze artificiali indetta e finanziata da
Hugh Loebner. L'idea del premio nasce dal
gioco dell'imitazione ideato da
Alan Turing, meglio noto come
test di Turing, cristallizzatosi su una formula non troppo diversa da quella proposta dal matematico britannico. Alcuni giudici, infatti,
chattano per cinque minuti con un utente che non possono vedere e danno a ciascuno una sorta di livello di umanità. Alla fine vengono assegnati due premi, uno al
bot risultato più umano e l'altro all'...
umano più umano. In
Essere umani Brian Christian racconta della sua esperienza e di come si è preparato per la sua partecipazione, di fatto realizzando una ricerca su ciò che ci rende umani.
In ultima analisi, ciò che mi ha stupito di più del libro di Christian è come, utilizzando il semplice obiettivo di dimostrarsi umano durante il test di Turing, ci si avvicini a vari aspetti più o meno connessi tra loro, come l’intelligenza, il linguaggio, la compressione delle informazioni.
Il cuore del
Premio Loebner, il moderno
test di Turing, sono le ricerche sui
bot. Questi sono essenzialmente dei programmi di
chat (da cui il nome più preciso di
chatterbot) che dialogano con gli utenti cercando di simulare degli esseri umani nel modo migliore possibile.
Il primo
software di questo genere fu
ELIZA, sviluppato nel 1966 da
Joseph Weizenbaum. A partire da
ELIZA i
bot si sono sviluppati sempre di più, riuscendo ad avvicinarsi in molte occasioni al superamento del
test di Turing. L'osservazione più interessante sull'argomento è che una delle principali applicazioni dei
bot è nell'ambito dell'assistenza psicologica: un
bot, infatti, si rivela un terapista migliore di un essere umano!
Ovviamente di possibili applicazioni se ne possono immaginare moltissime, dall'ambito letterario (vedi, ad esempio,
Le argentee teste d’uovo per un'interpretazione umoristica della vicenda), a quelli
politico, giornalistico e così via. E ci si aspetta che
potrebbero tranquillamente affrontare qualunque genere di lavoro, almeno nel momento in cui li si dota di corpi adatti a qualunque scopo.
Certo c'è da dire che il vantaggio dei
bot che hanno partecipato al
premio Loebner, e in fondo di un po' tutti i
bot che circolano in giro, è la loro specializzazione. I
bot del premio devono convincere i giudici che sono esseri umani, un compito leggermente più semplice che esserlo sul serio, proprio grazie alle possibilità che concede lo studio del linguaggio. Una delle caratteristiche di questi
bot, però, è una qual certa mancanza di creatività, non solo relativamente alla gestione della conversazione, ma anche nella capacità di cambiare argomento all'improvviso o in base agli spunti dell'interlocutore.
Questo, però, ci porta dritti alla delicata questione della progettazione di un'intelligenza artificiale e quindi a uno dei pionieri nel campo,
Claude Shannon, che ha tra l’altro anche contribuito allo sviluppo
teoria matematica della crittografia.