Per il secondo anno consecutivo l'edizione del
pi day del
Carnevale della Matematica è rappresentata da un numero pari, il 148. Per cui un benvenuto a tutti, sempre al solito orario
pi greco a tutti i nottambuli che hanno atteso la lettura puntuali alle 3:14, ma anche a quei lettori che hanno deciso di non lasciarsi travolgere dalla passione per il
numero di Archimede e hanno atteso la mattina per leggere cosa i
matematti hanno preparato per voi per festeggiare degnamente il
pi day 2021.
Prima di immergerci tra i contributi, andiamo, come da tradizione, a riassumere alcune delle proprietà del numero di questa edizione.
Come detto il 148 è un numero pari con i seguenti divisori: 1, 2, 4, 37, 74, 148. Poiché la loro somma, 148 escluso, è 118 < 148, il numero è detto difettivo.
Ha anche una caratteristica geometricamente interessante: è un numero ettagonale e 26-gonale. In generale un numero poligonale è un numero che può essere rappresentato utilizzando un poligono regolare. La regola è semplice: si prendono tanti pallini quanti sono quelli che servono per rappresentare il numero in questione e li si dispongono, riempiendo anche l'area interna, per formare un poligono regolare. Nel caso del 148 si riescono a realizzare due poligoni regolari, uno di 7 e l'altro di 26 lati.
In particolare nel caso dell'ettagono, questi ha anche un pallino al centro, rendendo il 148 un numero ettagonale centrato. Dal punto di vista matematico un numero ettagonale centrato è ricavato dalla formula
\[\frac{7n^2 - 7n + 2}{2}\]
Fa anche parte di ben 5 terne pitagoriche, (48, 140, 148), (111, 148, 185), (148, 1365, 1373), (148, 2736, 2740), (148, 5475, 5477), oltre a essere un numero congruente. Questo genere di numeri sono tutti naturali e sono equivalenti all'area di un triangolo rettangolo con lati razionali (ovvero costituiti da frazioni di numeri interi).
E' anche un numero di Ulam, un genere di numeri che abbiamo già incontrato in occasione del
Carnevale #131, un numero odioso (ma la cosa verrà approfondita in un contributo presente nel
Carnevale) ed è persino palindromo, o almeno lo è la sua rappresentazione in base 6: 404.

Vignetta di
Antonino La Barbera in corso di pubblicazione su
EduINAF
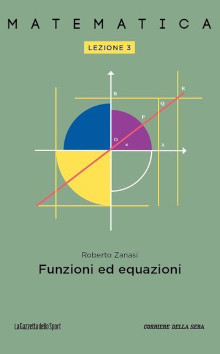














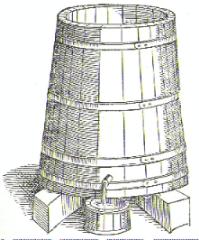 Dopo la
Dopo la 



