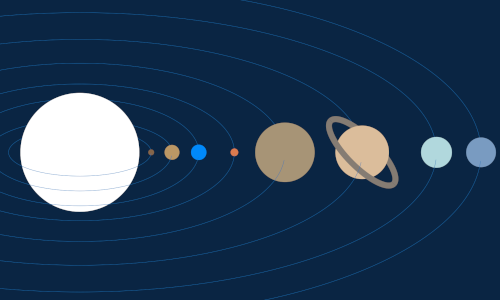Narrazione leggera, brillante e ironica dei nostri primi passi su Marte

Foto dell'area di impatto di
Schiaparelli sul suolo marziano
La missione
ExoMars 2016 ha avuto un doppio esito, positivo per il satellite di comunicazioni messo in orbita intorno a Marte, e che servirà per la missione successiva, negativo per il
lander, che invece si è schiantato su Marte. L'
ammartaggio di
Schiaparelli ha, infatti, avuto esito negativo a causa di un non meglio identificato problema tecnico: a quanto pare il computer ha frenato il
lander per appena 3 dei 30 secondi previsti. La causa di questo malfunzionamento potrebe essere una
malprogrammazione del software o una difficoltà nell'incrocio dei dati provenienti dai sensori.
Ovviamente ci sarà nei prossimi quattro anni la necessità di capire l'origine del problema, per poter ridefinire la missione che dovrebbe portare nel 2020 un vero e proprio
rover, come il famoso
Spirit della Nasa.
Questi dispositivi mobili che vengono periodicamente inviati su Marte non si muovono di loro iniziativa, ma vengono guidati da Terra, con grande precisione, attenzione e lentezza, essenzialmente a causa dei 14 minuti per inviare e ricevere informazioni dal pianeta rosso. Tra gli attuali
Autisti marziani che lavorano presso il JPL della Nasa c'è anche l'italiano
Paolo Bellutta che, coadiuvato da
Stefano Dalla Casa, ha scritto un'interessante guida per i suoi aspiranti colleghi!
L'uomo di Marte ha esplorato le possibilità di sopravivenza di uno scienziato rimasto solo sulla superficie marziana. Questo vero e proprio
Robinson Crusoe del terzo millennio (e si spera che su Marte ci andremo entro questo millennio!) può essere considerato come un passo intermedio (ancora da compiere) nel processo di colonizzazione del pianeta rosso, iniziato, seppure in maniera indiretta, nel 1964 grazie alle prime foto scattate dal
Mariner 4, la prima delle sonde terrestri a riuscire nell’impresa di avvicinarsi a sufficienza al pianeta.
Fino ad allora l'osservazione di Marte era stata fatta da lontano utilizzando il classico strumento dell'astronomo: i telescopi. Sebbene le osservazioni rislagono fino agli albori della civiltà, i più noti osservatori del pianeta sono stati considerati
Giovanni Schiaparelli e
Percival Lowell. In particolare quest'ultimo, a causa di una cattiva traduzione degli scritti dell'italiano, suggerì che sulla superficie marziana abitasse un popolo tecnologicamente avanzato. L'equivoco era nato a causa della traduzione del termine "canali", reso in inglese con "
canals", utilizzato per i "canali artificiali", mentre Schiaparelli intendeva "canali naturali", suggerendo così un'idea forse meno forte di vita intelligente sul nostro vicino cosmico, ovvero quella di presenza di acqua corrente su un altro pianeta del sistema solare.
Ad ogni buon conto le idee di Lowell scatenarono gli scrittori di fantascienza, in particolare
Edgar Rice Burroughs, che così trovò materiale per ideare la
saga di John Carter eroe di
Barsoom (il nome natio di Marte secondo Burroughs), e
H.G. Wells con la sua
Guerra dei mondi.
Tornando all'esplorazione di Marte, il passo successivo furono le missioni
Viking, 1 e 2. Esse erano costituite da un
orbiter e da un
lander, con quest'ultimo che avrebbe effettuato l'esplorazione vera e propria del suolo marziano. Possiamo considerarli come i veri primi pionieri della possibile futura colonizzazione del pianeta.
Tra alterne fortune l'importante passo successivo avviene nel 1997 con l'entrata in orbita del
Mars Global Surveyor e il successivo atterraggio del
Pathfinder il 4 luglio del 1997, che però non arriva solo: deposita, infatti, il primo
rover della storia del pianeta, il
Sojourner. E ovviamente a guidarlo, da Terra e con un ritardo di 14 minuti circa, c'è il primo
team di autisti marziani!