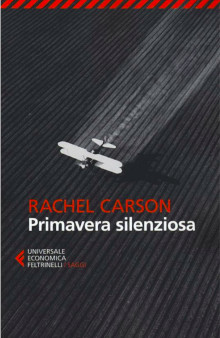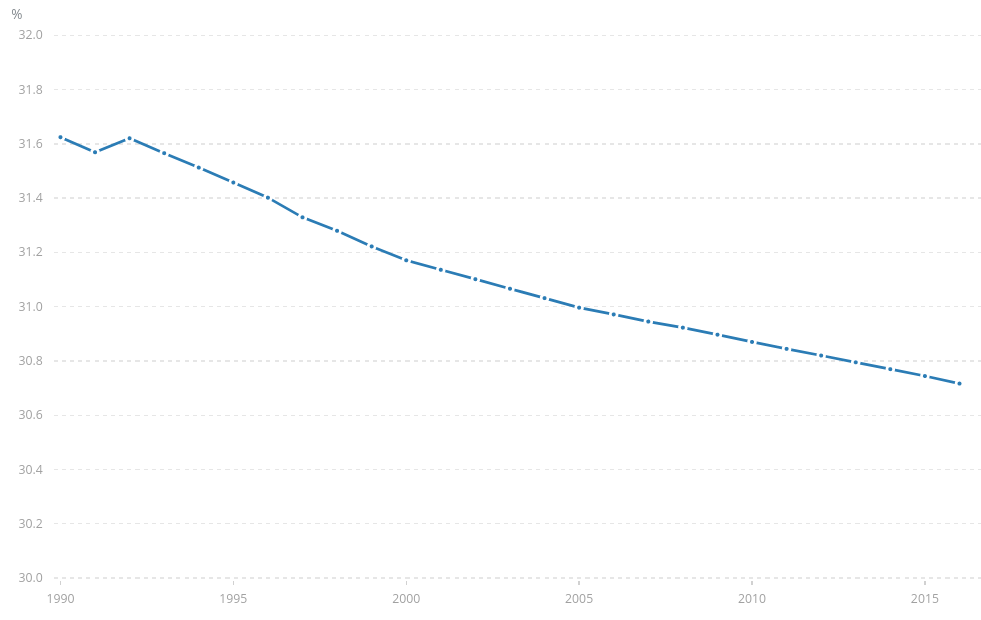Ernest Thompson Seton è stato uno dei più importanti naturalisti d'oltreoceano. Nato il 14 agosto del 1860 a South Shields nella contea di Durham in Inghilterra, crebbe in Canada, dove la famiglia si trasferì intorno al 1866. Alcuni anni dopo, però, tornò in Gran Bretagna, a Londra, dove perfezionò la sua tecnica nel disegno e nell'illustrazione presso la
Royal Academy. Al compimento del suo 21.mo anno d'età, il padre gli chiese la restituzione dei soldi spesi per crescerlo, inclusi quelli per la sua istruzione, e tutto ciò nonostante gli scarsi invii mometari ricevuti durante il periodo londinese che lo costrinsero a lavorare. Seton, dopo aver onorato il "debito", non parlò mai più con il padre.
La vita di questo brillante e talentuoso artista fu, in effetti, anche piuttosto avventurosa e in particolare sono tre gli episodi che
Jiro Taniguchi su testi di
Yoshiharu Imaizumi utilizzano nel loro poderoso
manga Seton: l'episodio più noto della caccia al lupo
Lobo in
Lobo, il re dei lupi, con cui si apre la serie; quindi il periodo dell'infanzia del naturalista presso la famiglia del cugino Tom nei pressi di Fenelon Falls nel secondo volume,
Il ragazzo e la lince; quindi la caccia a
Il cervo di Sandhill nel terzo volume. La serie viene arricchita anche da un quarto
tankobon (anche se la dicitura, forse, è riduttiva, vista la foliazione), Monarch, l'orso del monte Tallac, che ricostruisce la vicenda del temibile Monarch che Seton ha riscostruito nel suo libro
Monarch, The Big Bear of Tallac del 1904.
Nei quattro volumi di
Seton i due autori hanno, ad ogni modo, un unico, fondamentale intento, evidente sin dal primo
tankobon: mostrare lo stretto rapporto di Seton con la natura, la sua capacità di avere una visione del mondo naturale molto avanzata per l'epoca. I due autori, però, non si accontentano solo di questo e soprattutto nei primi tre volumi, quando alla vicenda principale alternano
flashback sulla vita di Seton, inseriscono anche piccole digressioni sui naturalisti che hanno influenzato il giovane Seton: persone come
William Brodie, dentista di professione e naturalista per passione che fu il primo mentore di Seton; o ancora
Joseph Wolf, uno dei primi artisti a specializzarsi in storia naturale, che Seton conobbe personalmente; ornitologi e naturalisti come
John Audubon o
Henry Thoureau, sui cui scritti Seton studiò per prepararsi al lavoro vero e proprio di naturalista.